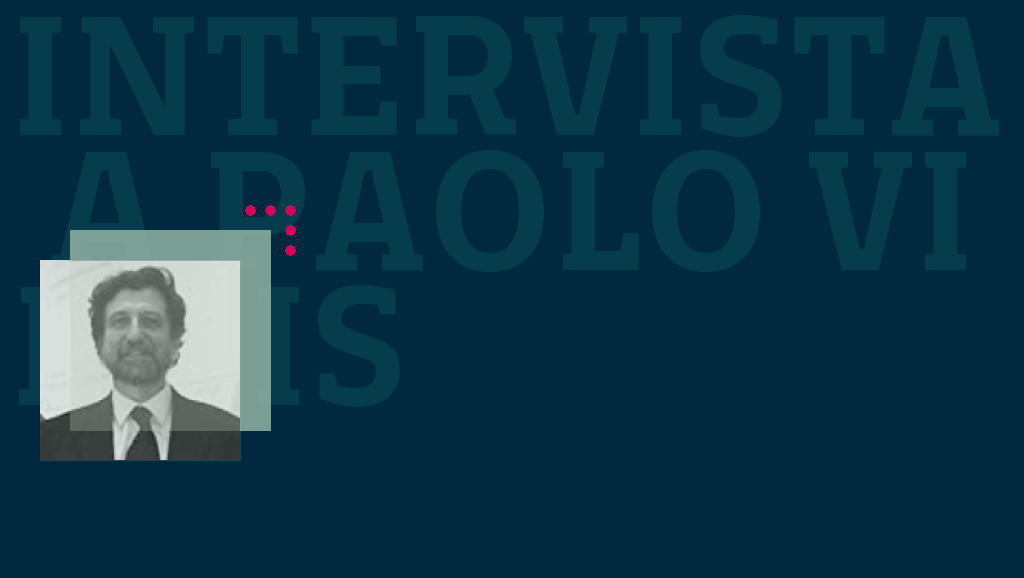Sui rischi delle nuove tecnologie applicate alla vita e sul principio di precauzione abbiamo chiesto il parere di Paolo Vineis, titolare della cattedra di statistica medica all’Università di Torino.
1- Ritiene che la ricerca per sviluppare nuove tecnologie applicate agli organismi viventi e la valutazione scientifica dei rischi delle biotecnologie vadano di pari passo?
Assolutamente no. Mi pare che la ricerca attuale sia volta o a studiare i fenomeni biologici di base (senza un’applicazione nel breve periodo), oppure le applicazioni tecnologiche sfruttabili commercialmente. C’è un grave gap fra lo sviluppo di queste ultime (le cosiddette biotecnologie) e lo studio del loro potenziale impatto sull’ambiente e sulla salute umana. Per citare un fenomeno che conosco meglio, e denunciato da anni: delle molte migliaia di nuove sostanze chimiche che vengono immesse sul mercato solo un numero limitato viene sottoposto regolarmente a test relativi alla cancerogenicità. Il National Toxicology Program americano è stato drasticamente ridimensionato negli ultimi anni, e in generale si presta oggi meno attenzione alla necessità di sottoporre a screening tossicologici accurati le sostanze chimiche con cui veniamo a contatto. Non vorrei che qualcosa di simile avvenisse per le nuove tecnologie.
2- Chi dovrebbe finanziare le ricerche sui rischi delle biotecnologie?
Le ricerche sui rischi delle biotecnologie (termine molto vago che include un gran numero di tecniche diverse) dovrebbero essere finanziate con denaro pubblico, anche se un ruolo del privato non è affatto da escludere. Anzi, a rigore, secondo il principio di precauzione spetta a colui che immette modifiche nell’ambiente l’"onere della prova" della non pericolosità, mentre non spetta a chi subisce l’esposizione l’onere della prova dell’avvenuta intossicazione. Tuttavia le dimostrazioni di non pericolosità – anche condotte a carico del privato – devono avvenire con un forte controllo, a monte e a valle, da parte del pubblico.
3- In una lettera inviata a La Repubblica, alcuni scienziati italiani si schierano a favore del principio di precauzione e sostengono che debba essere applicato alle biotecnologie. Altri ricercatori invece pensano che questo principio rappresenti un ostacolo e che la sua applicazione potrebbe frenare l’introduzione di tecnologie utili. Lei come la pensa?
Il discorso sul Principio di precauzione è molto delicato e richiede grande attenzione.
Sono convinto che un’applicazione troppo rigida porti alla paralisi. Basti pensare a qualche esempio storico: quando nella Francia dell’Ottocento iniziarono a essere introdotte le vaccinazioni, si manifestò un forte movimento di opposizione. Quello che è meno noto è che tale movimento usava come una delle principali argomentazioni il pericolo di commistione tra specie animali. Una bellissima vignetta del tempo mostra una folla di individui che, dopo essersi sottoposti alla vaccinazione, si vedono spuntare teste di mucca dalle braccia e dal collo. Una traccia di questo atteggiamento – che fa pensare al classico dell’antropologia Purezza e pericolo di Mary Douglas – la troviamo oggi, quando l’immaginazione collettiva attribuisce al cibo geneticamente modificato proprietà che esso non ha e non può avere: per esempio sembra che molti siano spaventati all’idea che attraverso gli OGM si ingurgitino pezzi di DNA, ignorando evidentemente che qualunque cibo degno di questo nome contiene quantità rilevanti di DNA. Detto questo, la fiducia acritica nello sviluppo delle tecnologie ha portato per molti anni a sottostimare gravemente gli effetti delle radiazioni, a posporre misure preventive per sostanze cancerogene, a sottostimare gli effetti sul clima delle immissioni nell’atmosfera, eccetera. Perché non cercare di prevenire e prevedere le conseguenze delle nostre azioni sull’ambiente e la salute? Solo una modestissima parte delle spese di innovazione tecnologica è usata per la ricerca delle implicazioni ambientali. Questo è il principio di precauzione: un atteggiamento responsabile, che rinuncia al fideismo nei confronti delle nuove tecnologie, senza pregiudizi.
4- Che ruolo dovrebbero avere gli scienziati nelle decisioni prese a livello politico?
Questa è di gran lunga la domanda più difficile. Io non credo che gli scienziati debbano impedirsi di esprimere le proprie vedute sociologiche e politiche, per almeno due buoni motivi. Per prima cosa, in quanto cittadini è normale che abbiano un punto di vista politico, ma al contempo sono particolarmente qualificati grazie alle competenze di cui dispongono. In secondo luogo, se gli scienziati rendono pubblico il loro punto di vista, questo non rimarrà implicito nel nome della neutralità della scienza. Quello che più temo è la mancanza di consapevolezza da parte degli scienziati, che spesso si associa a una certa arroganza: mi riferisco per esempio al libro di Lomborg, molto criticabile sul piano scientifico, che si propone come il testo che "dice la verità" basata sui dati, ridimensionando le posizioni ideologiche degli ambientalisti. Se poi ci si documenta su ciascuno degli aspetti toccati dal libro si vedrà che esso è almeno altrettanto ideologico delle posizioni di alcuni ambientalisti (consiglio ai fan di Lomborg il libro molto più serio di Tony McMichael Human frontiers, environments and disease, Cambridge University Press, 2001, purtroppo non ancora tradotto in italiano). Quindi meglio l’esternazione del proprio punto di vista che una apparente neutralità. Nello stesso tempo il ricercatore deve essere molto prudente per non essere influenzato dai suoi pregiudizi a priori nella conduzione della sua ricerca. Io faccio ricerca, fra le altre cose, sugli effetti dell’inquinamento atmosferico: quando la comunità europea mi finanzia mi chiede di adottare un punto di vista non pregiudiziale, perché il suo interesse è l’acquisizione di informazioni, non di opinioni. Questo obiettivo può essere realizzato attraverso codici deontologici, protocolli scientifici rigorosi e il controllo da parte della comunità scientifica nel suo complesso.