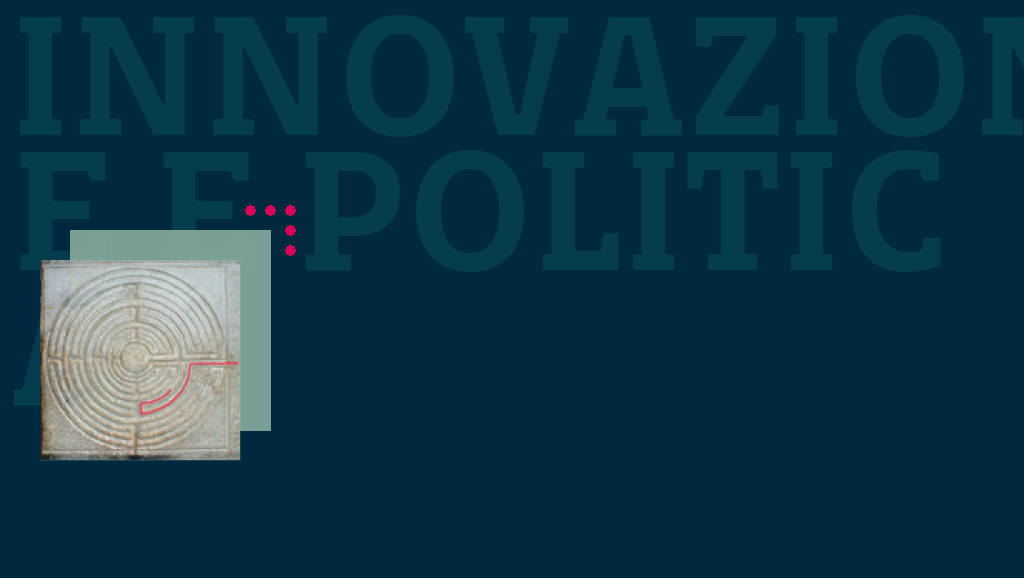Dopo “La responsabilità nell’innovazione“, pubblichiamo “Innovazione e politica” la seconda lezione di Piero Bassetti per il Corso Trasversale di Epistemologia della ricerca scientifica e tecnica del Politecnico di Milano. Un intervento tenuto nel febbraio del 2006 che verrà a breve pubblicato da Mondadori.
Innovazione e Politica
di Piero Bassetti
Nel 2004 il tema dibattuto era stato “La responsabilità dell’innovazione”, un tema centrale per la missione della Fondazione Giannino Bassetti. Quest’anno affronteremo un altro tema di grande importanza e attualità, “Innovazione e Politica”.
Va detto che il tema odierno è stato scelto con cura e con una motivazione precisa, dato che la volta scorsa, dibattendo di responsabilità dell’innovazione – questo tipo di responsabilità esiste?, se esiste, come si configura nella fattualità?, se si configura concretamente, a chi è permesso e chi deve esercitarla? – la questione che aveva suscitato il maggior interesse era stata proprio la questione della responsabilità politica.
Abbiamo visto che l’innovazione spesso contribuisce a far avanzare la storia dell’uomo (alcuni esempi eclatanti si sono avuti con l’introduzione della locomotiva, del motore elettrico, dell’automobile, dell’aeroplano, ma anche del piumone, della minigonna eccetera). Ci siamo pertanto accorti che chi innova contribuisce a fare la storia e in questo senso fa politica. Dalla discussione era anche emerso che non tutti i fatti o le verità che si riferiscono all’innovazione sono conosciuti e compresi dall’opinione comune e che a volte nemmeno i ricercatori ne hanno piena consapevolezza. In definitiva, è necessario sottolineare che quasi sempre chi innova non si rende conto di fare anche politica.
In ogni caso chi fa innovazione, di questo suo far politica non sente la responsabilità.
A sua volta la politica non ritiene di avere la responsabilità di indirizzare l’innovazione
Anche perché ritiene che questo sia un compito del mercato. Un compito che solo in pochi casi (es: difesa, sicurezza, comunicazione) spetta direttamente alle istituzioni di governo e per il quale, comunque, la politica non dispone di una strumentazione adatta…
Tutto ciò malgrado il tema sia invece di fondamentale importanza per il nostro destino e debba essere affrontato e fatto proprio non solo dagli uomini politici ma anche dagli uomini di tecnica e di scienza.
Ecco perché, approfittando della riflessione e dell’esperienza accumulata dalla Fondazione Giannino Bassetti in questo campo, ho proposto di focalizzare la discussione di quest’anno sul tema innovazione e politica. Di qui il titolo.
Un titolo che vuole evocare la delicata questione di come si può mettere l’Innovazione (che, abbiamo visto, è un fatto politico, molto spesso non percepito come tale) e la Politica, (che sull’innovazione dovrebbe esercitare l’indirizzo e molte volte si astiene dal farlo) in un corretto rapporto nel quale tanto l’innovazione che la politica possano svolgere la loro funzione in coabitazone ma anche in convergenza di fini.
Mi propongo di sviluppare il tema odierno cominciando a parlare dell’innovazione. Lo farò riflettendo su alcuni meccanismi propri dell’innovazione.
Abbiamo già visto che quando si produce un’innovazione, in essa confluiscono un “di più” di sapere e un “di più” di potere. In teoria, l’aggiunta di sapere dovrebbe essere fornita da chi ricerca, mentre il sovrappiù di potere lo aggiungerebbe colui che ha capitale o legittimazione a creare le circostanze adatte per disporne. Infatti, chi ricerca producendo un aumento di sapere (lo scienziato, il ricercatore, il tecnologo, il creativo) non è di solito lo stesso soggetto che si attiva per ottenere un sovrappiù di potere. Un conto è adoperarsi per allargare il tempio della conoscenza; tutta un’altra faccenda cercare di fare soldi o perseguire qualche altra propria finalità extraeconomica. Indirizzare la società verso un ideale di bene comune, e cioè fare politica, è un’altra cosa ancora. In tutti questi casi, le motivazioni, le logiche operative, le deontologie, i valori, sono ben diversi (e anche le rispettive epistemologie lo saranno).
Lavorare per mettere a punto qualcosa di cui si possono prevedere gli effetti è una cosa, un’altra cosa è lavorare per promuovere l’innovazione a proposito della quale Daniel Callahan dice: “Once ideas or innovation technologies are out in society they often, very often, pass beyond the control of their inventor”. Insomma, è difficile prevedere fino in fondo tutti gli effetti dell’innovazione.
Certo, in un ambito pratico questa differenza di ruoli tende a ridursi (questo concetto è stato ben spiegato da Richard Nelson nella sua lecture organizzata dalla Fondazione Giannino Bassetti all’Università Bocconi). Infatti, nel concreto, quando il problema è quello di introdurre un’innovazione – che si tratti di un prodotto o di un processo, di un’impresa, di un ospedale o di un sistema d’arma – i ricercatori, i tecnologi, i portatori di potere economico capitalistico, di potere organizzativo o imprenditoriale, di potere politico amministrativo, tendono a lavorare insieme. Questo fatto non è privo di conseguenze dato che, quando si confondono i ruoli, si confondono anche le logiche di comportamento: chi collabora all’innovazione, anche quando viene dal mondo del sapere, finisce col diventare un attore del complicato processo in atto e ad assumere comportamenti pratici le cui premesse epistemologiche sono assai più complesse di quelle che un’astratta ipotesi di un “sacerdote della scienza” comporterebbe. Vale anche il caso contrario: qualche volta anche fattori economici o istanze politiche vengono investite del gusto della ricerca.
E’ ovvio che la decisione sulla realizzazione e lo sfruttamento dell’innovazione in questione verrà presa da chi fornisce il potere necessario affinché essa sia realizzata (il tutto è naturalmente in funzione del potenziale di successo di quest’ultima). Il successo di un’innovazione nelle nostre società viene, in genere, determinato dal mercato sulla base di parametri che solo nel caso di beni pubblici, destinati a rimanere tali, non saranno quelli economici.
Ora è proprio qui che il problema del rapporto tra innovazione e politica si manifesta.
Perché il mercato non fa politica. Quantomeno non fa politica nello stesso senso in cui la fanno gli organi istituzionali sedi specifiche di confronto politico.
Certo anche il mercato fa scelte: se è vero che è lui a decretare il successo o l’insuccesso di una innovazione che sia stata sottoposta al suo giudizio.
Ma il suo modo di fare scelte è ben diverso da quello degli organi politici
Il continuo referendum dei consumatori che in esso si svolge può sì determinare il successo di un’innovazione, ma solo quando questa ha potuto essergli presentata in quanto realizzata.
Quindi ex post rispetto al momento della decisione di fare incontrare sapere e potere per inverare qualcosa che prima era improbabile e così innovare.
Inoltre, i giudizi del mercato, oltre che formulati ex post, tendono ad essere giudizi formulati sulla base di considerazione di gradimento a breve, sono formulati in termini di confronto fra costi e prezzi e spesso non dipendono da valutazioni di incertezza o rischio extraeconomico. Insomma, le cosiddette “esternalità” non vi trovano posto. Si tratta, quindi, di scelte e giudizi non politici o, quanto meno, che non fanno parte della politica affidata alle istituzioni democratiche. Perché l’innovazione possa dirsi determinata e diretta dalla politica occorre ben altro.
Occorre che la finalità perseguita e il sovrappiù di potere messi a disposizione possano rispondere a finalità politicamente predefinite ex ante da soggetti motivati in termini politici. Solo in questo caso ognuna delle componenti coinvolte viene messa in condizione di dover assumere chiare corresponsabilità politiche e le istituzioni politiche possono ritenersi coinvolte. Solo allora la prassi dell’innovazione diventa una prassi pienamente politicizzata e l’innovazione e la politica sono poste in un chiaro rapporto di codeterminazione (un caso paradigmatico di quanto si va dicendo è stata la costruzione della prima bomba atomica nei laboratori di Los Alamos).
Ma possiamo dire che i casi come quello, nei quali la politica, chiaramente e consapevolmente, si è assunto il ruolo di decidere quale innovazione perseguire o quale rifiutare siano frequenti?
Possiamo in altri termini dire che nelle nostre società sia frequente il caso di una politica che ispira e controlla l’innovazione; che esprima per questa un vero e proprio indirizzo non solo quantitativo ( vogliamo più innovazione! ) ma anche qualitativo (perseguiamo questo tipo di innovazione)?
Credo si possa tranquillamente affermare che ciò non avviene o avviene di rado.
Perché?
In primo luogo per la peculiarità, la natura intrinseca dell’innovazione: come realizzazione dell’improbabile, come regno dello sconosciuto, del difficile, dell’imprevedibile, dell’incerto, del rischio, essa infatti pone problemi di decisione che contrastano notevolmente con il modus operandi dei processi decisionali delle istituzioni democratiche.
Alcune procedure, che di questi sono tipiche – come trasparenza, partecipazione, consenso; ma anche norma, garantismo, principio di maggioranza, di precauzione – non vanno d’accordo con le modalità di promozione, indirizzo, controllo dell’innovazione che gli organismi politici, legati alla regola di maggioranza, normalmente sono tenuti ad adottare.
In secondo luogo perché la politica ha, in materia di innovazione, fatto la scelta di ignorarne il contenuto precipuamente politico; di accomunarla alla più generale problematica della miglior collocazione delle risorse e perciò ha scelto, come dicevamo, di delegarne le determinazioni al mercato: come il luogo migliore nel quale la liberta creativa di sempre nuove combinazioni produttive, può manifestarsi; l’impulso degli imprenditori svilupparsi appieno, le forze del rinnovamento distruttivo svolgere il loro lavoro E’solo il mercato, si è detto, che può esercitare un vaglio accurato di ciò che di innovativo gli venga proposto sulla base del maggior o minor consenso ottenuto sul campo da ciò che viene sottoposto al suo giudizio.
C’è stata insomma una precisa divisione di compiti istituzionali: è il mercato che in una società capitalistica è chiamato a decidere la direzione dello sviluppo.
Le istituzioni politiche con la loro capacità di regolazione sono semmai chiamate a operare a monte e a valle.
Se ne deduce che le ragioni di scarso controllo politico dell’innovazione da parte della politica non sono solo occasionali o contingenti ma sono riconducibili a ragioni molto serie di tecnica istituzionale: al fatto che le nostre istituzioni democratiche non sono ancora state adeguate alle sfide che la scienza e le nuove forme capitalistiche propongono.
Non ha contato finora la pur crescente consapevolezza che siamo ormai in una situazione nella quale la scienza scopre ogni giorno di più di non sapere, la tecnica di non poter sempre maneggiare il rischio, il mercato di non essere predisposto per scelte ex ante.
Certo la politica percepisce di essere in difficoltà.
Ma abituata a scegliere tra giudizi di valore incerti ma su fatti certi, stenta a inventarsi tanto una epistemologia adatta a consentirle di scegliere tra valori e fatti entrambi incerti quanto una prassi familiarizzata con la gestione del rischio
Non c’è perciò da stupirsi se il governare un fenomeno sfuggente come l’innovazione si rivela sempre più difficile (l’esempio delle recenti vicende legate alle cellule staminali è illuminante al proposito).
In definitiva, come già sottolineato all’inizio, innovazione e politica si rivelano mondi davvero difficili da raccordare.
Possiamo rassegnarci?
La mia risposta è ovviamente no.
Anche se è ben lungi da me ogni presunzione di saper indicare la soluzione!
Tutt’al più, credo di essere in grado di fornire qualche linea di indirizzo.
In primo luogo si tratta di accrescere la consapevolezza che il problema esiste e la politica, anche quella nostrana, farebbe bene ad occuparsene
Troppe volte si ha l’impressione che la politica si riduca a pensare che più innovazione c’è meglio è. E si fermi lì.
Quando invece basta alzare gli occhi per vedere come stiano accumulandosi problemi micro e macro: dal clima alla biogenetica. alla nanotecnologia al nucleare. che non solo dovrebbero occuparci ma che riassunti nella formula dello sviluppo sostenibile sono già materia di approfondite riflessioni di altri centri di potere che vanno dall’ONU, alle multinazionali, ai no-global.
In secondo luogo si tratta per gli uomini di scienza e di tecnologia di immergersi anch’essi di più nello sforzo elaborativo che in sede cultural-politica è storicamente in atto.
Insomma, a secoli di distanza, le posizioni di Galileo non bastano più.
In terzo luogo, bisognerebbe rifiutarsi, tutti quanti, di farsi intrappolare in assurdi palleggi di responsabilità sia per quel che riguarda i ricercatori (che si chiamano fuori e si alienano) sia per quel che concerne i politici (che devono capire che le decisioni importanti, anche se difficili, non possono essere delegate a nessun altro potere). La politica vera è quella che decide dove deve andare la società che rappresenta ed è efficace e dà dei risultati quando cessa di essere politique politicienne.
In quarto luogo, si tratta di convincere i politici che questo nuovo problema è più complesso di quelli che essi sono stati fin qui abituati a trattare. Lo è per ragioni intrinseche, in quanto alcune variabili interne ai processi di innovazione, come il rischio, la responsabilità, la complessità stanno mettendo in crisi i tradizionali strumenti di governance come l’informazione, l’amministrazione, la legge, il garantismo, la privacy, eccetera. Quando Bruno Latour in questi stessi locali (lo abbiamo ricordato l’anno scorso) evocava la necessità di un “Parlamento delle Cose”, non lo faceva solo per affermare che idealmente “anche il fiume sporcato da un processo chimico nuovo… dovrebbe essere in qualche modo rappresentato”, ma perché era consapevole che il contesto, lo scenario entro il quale un’innovazione si trova ad agire ne condiziona il significato.
In quinto luogo, si tratta di comprendere il perché dell’insufficiente funzionamento del metodo maggioritario quando è applicato alle decisioni difficili (anche qui val forse la pena di riprendere un pensiero già citato l’anno scorso, quello di Amartya Sen che sostiene che “la democrazia non si esaurisce in quella cosa che l’occidente ha sperimentato nelle forme che noi conosciamo, ma è il concetto di decisioni dialogate tra il potere e il demos che le subisce”).
In sintesi, è necessario ammettere che siamo tutti abbastanza sprovveduti per quel che concerne questa problematica complessa e nuova, dato che non possediamo la cultura necessaria che ci consentirebbe di superare quell’atteggiamento di alienazione scientista che il riduzionismo ha introdotto un po’ dappertutto: tra gli scienziati, i tecnici, gli imprenditori, gli amministratori e i politici.
Certo intravediamo un quadro di responsabilità che ci fa sentire inadeguati e ci spaventa. Ma dobbiamo capire che esso è il risultato di qualcosa che abbiamo creato noi e che siamo chiamati a comprendere e domare; non già a rifiutare.
Dichiarare i limiti della politica non può voler dire deresponsabilizzarla.
Allo stesso modo, riconoscere l’incompetenza dei politici in un ambito delicato come quello dell’innovazione non vuol dire assolverli se non affrontano al meglio delle loro possibilità i problemi in campo. Lo stesso vale per gli imprenditori, i pubblici amministratori e i ricercatori. Non è che gli scienziati, i tecnici, gli imprenditori e gli amministratori possono mettersi a fare il mestiere dei politici, ma non possono neppure smarcarsi completamente dalla dimensione politica intrinseca alle problematiche del loro agire.
E poiché oggi siamo prevalentemente fra ricercatori, occupiamoci un poco di voi.
Quali possono essere alcune considerazioni più specificamente adatte a persone come voi?
Innanzitutto una, di carattere generale: il vostro mondo, il mondo di chi fa ricerca non può sfuggire al dovere di porsi questi problemi: deve farlo e col massimo impegno.
Man mano che la scienza progredisce verso nuovi campi suscettibili di generare profonde conseguenze su qualità e rischio sociale (si pensi alla biologia, alle nanotecnologie, alle scienze cognitive, alla stessa informatica, per non parlare del nucleare o della farmacologia), non è pensabile che la problematica che concerne le sue applicazioni alle concrete condizioni di vita (dal punto di vista sia micro sia macro) possa essere affrontata senza che la stessa scienza possa guidarne i processi di sviluppo.
Il fatto che paradossalmente la politica tenda piuttosto a perdere che ad accrescere la sua capacità di presenza consapevole perché allontanata dalle sue crescenti debolezze – legate alla crisi di governance che localizzazione, crisi dello stato nazionale, mediazione mediatica, patologie democraticiste, inadeguatezze della cultura diffusa progressivamente introducono – non alleggerisce certo, semmai accresce la tensione morale e psicologica di chi è chiamato a far ricerca utilizzabile in ambiti innovativi e non può quindi evitare di porsi domande di senso e responsabilità sul suo lavoro.
Segue a ruota una considerazione di tipo deontologico: come deve comportarsi il ricercatore quando il politico decide di coinvolgerlo in decisioni che hanno valenza politica? A mio parere, in questo caso dovrebbe innanzitutto pretendere chiarezza da parte delle istanze politiche. Ciò non significa evitare semplicemente delle corresponsabilità nel processo decisionale: se chi fa innovazione fa effettivamente politica, allora anche il ricercatore, durante il processo di ricerca che produce innovazione, fa politica e deve esserne consapevole.
Ma ora mi pongo un’altra domanda: il politico è disposto a riconoscere il ruolo politico del ricercatore? Purtroppo, la risposta a questo quesito è: quasi mai, dato che la maggioranza dei politici è convinta che primato della politica significhi primato del politico. Insomma, il politico ritiene che le decisioni che contano siano quelle riconducibili alle istituzioni cui è preposto: che sono quelle organizzate attorno al “controllo della violenza legittima” e alla legittimazione del voto. Purtroppo, al politico sfugge nella maggior parte dei casi concreti che una corretta applicazione del suo potere a un fenomeno come l’innovazione implica comportamenti del tutto diversi. Un conto è, infatti, prendere decisioni su quello che si sa con certezza; un conto è prenderne su argomenti e fatti poco conosciuti o incerti. In questa sua vera e propria situazione di “ignoranza”, il politico si convince che per risolvere il problema possa bastargli una consulenza. Così facendo mette il consulente nell’assurda posizione di chi è, di fatto, chiamato a decidere per lui. Ne consegue che, spesso, un rapporto cosi impostato, nuoce a entrambi.
Certo la responsabilità di decidere su valutazioni di valori, interessi, opportunità applicate a fatti o situazioni che essendo note sono decidibili secondo i normali processi politici spetta al politico.
Ma quando si tratta di situazioni solo parzialmente note la responsabilità di riportare la conoscenza dei fatti al più alto livello di informazione possibile e di farlo assumendosi la responsabilità di valutarne le incertezze, va correttamente messa in comune, in un rapporto che non può limitarsi a quello di acquisto di un’expertise ma è chiaramente di co-decisione e perciò di co-responsabilità
Se il politico può essere chiamato a decidere anche in deficit di informazione – perché fa parte della sua preparazione – e anche della sua epistemologia – decidere su quello che non sa – anche l’esperto, in situazioni di questo tipo è tenuto a non limitarsi a dire solo quello che sa; ma a collaborare col politico per assumere insieme a lui le responsabilità di quello che, anche insieme, non possono sapere. Come appunto accade spesso quando si decide di Innovazione.
Solo un approccio di corresponsabilità può infatti evitare il ricorso alla pseudo-soluzione rappresentata dall’inversione dei ruoli tipica della situazione tecnocratica: una pseudo soluzione nella quale la politica non viene affatto meno, solo si traveste da tecnica per consentire al tecnico di fare politica senza dichiararlo e senza prendersi le relative responsabilità
Ma che cosa succede al ricercatore quando la politica è invece perfettamente consapevole dei limiti del proprio sapere? Il ricercatore può ricevere dal politico la delega di ogni responsabilità secondo lo schema già visto sopra. Tuttavia, può anche essere coinvolto in situazioni più complesse e sofisticate. Molteplici sono infatti le modalità attraverso le quali la politica ha cercato sostegno presso i depositari del sapere. Dai maghi agli aruspici, dalle consulenze ai Consigli Superiori, dalle Corporazioni alle Accademie, dalle Commissioni ad hoc ai consessi di Universitari o di Saggi, la parte politica ha applicato sempre uno schema chiaro che si può sintetizzare in una richiesta precisa: per decidere abbiamo bisogno di saperne di più; dotateci di un po’ di quel sapere che a noi manca e che voi dovreste possedere. Questo schema, nelle società liberali di impianto borghese con professionalità suddivise e organizzate, ha funzionato finché la scienza e le professioni partivano dal presupposto di sapere tutto ciò che si poteva sapere. Quando però anche la scienza ha cominciato a prendere coscienza delle molte aree nelle quali il vero sapere consisteva nel sapere di non sapere, anche questo tipo di atteggiamento ha cominciato a scricchiolare. Ecco perché recentemente qualche puntuale riflessione sull’argomento è stata pur fatta da chi si pone il problema del rapporto tra scienza e politica rinunciando al “modello lineare” ben descritto da Pielke nel suo recente libro “Scienza e politica” come “quella visione ontologica ed epistemologica del ruolo della scienza nella società basata sul presupposto che la scienza debba produrre necessariamente esiti politici, debba cioè rivestire un ruolo, o forse il ruolo centrale nel confronto politico”.
Si tratta di una rinuncia che mette in discussione quell’eccesso di sicurezza della presunta certezza scientifica derivabile dal riduzionismo sperimentalista, l’assunto epistemologico che è stato per anni un sostanziale limite a una gestione dell’innovazione compatibile con gli obbiettivi di sviluppo sostenibile gestito dalla politica.
Una rinuncia che apre la strada alla proposta di una figura di scienziato, o di tecnologo intesi come “onesti mediatori”.
Investiti cioè dal ruolo di chi “non certo privo di opinioni politiche o eroicamente obbiettivo, [è in grado] di aiutare i responsabili delle decisioni a comprendere la gamma delle alternative che hanno di fronte a volte ampliandola; e le probabili conseguenze delle diverse opzioni”. Un ruolo per esercitare il quale essi “devono impegnarsi attivamente nei dibattiti di policy e ignorare l’idea che la scienza possa essere nettamente separata dalla policy e dalla politica.”
Ma anche il politico, in presenza di un ricercatore che si posiziona come “onesto mediatore” sarà obbligato a cambiare il modo di esercitare il suo ruolo.
Dovrà terminare la pretesa di poter scegliere senza sapere o sapendo solo di valori e non dei fatti.
Se allo scienziato sarà imposto di ricordarsi che “ogni forma di sapere che teorizzi la segretezza in nome della inaccessibilità, che concepisca come sovrumane le difficoltà che si incontrano sulla via del conoscere, che affermi il carattere iniziatici dell’accesso alla verità e la possibilità, riservata a pochissimi, di giungere all’episteme, apparirà irrimediabilmente connessa alla tesi di natura politica secondo la quale gli uomini non sono in grado di governarsi da soli ed hanno bisogno, come i bambini, di favole che li tengano lontano dalla verità”, allora al politico non potrà non essere imposto, con altrettanta forza, di ricordarsi che i fatti hanno una scorza dura.
Se il manufatto sembra essere diventato “la categoria trascendentale dell’essere” e la “volontà di potenza si esprime nella produttività devastatrice della tecnica” oggi è forse arrivato il tempo per tutti, ricercatori e politici, di ritrovarsi ancora una volta attorno alla antica saggezza dei Greci.
L’anno scorso avevo accennato al mito secondo il quale Minerva nasce dalla testa di Zeus per evitare che l’incontro tra scienza e potere possa generare strapotere. Quest’anno mi piacerebbe concludere il mio intervento con le parole di Paolo Rossi che al termine di una sua lettura in ricordo di Carlo M. Cipolla, intitolata “Dedalo e il Labirinto – L’uomo, la natura, le macchine”, ci richiama il mito di Dedalo che “offre agli uomini contemporaneamente e congiuntamente le vie della perdizione e le vie della salvezza: una stessa persona ha costruito il labirinto ed ha costruito il filo utilizzato da Arianna per uscire dal labirinto. La tecnica è ambigua, per essenza: produce il male e offre i rimedi al male… Stiamo costruendo il labirinto e contemporaneamente tentiamo di costruire il filo di Arianna. Quel filo non ci verrà regalato… Possiamo fare affidamento solo su Dedalo”.
E Dedalo, cari amici, ai giorni nostri siete voi, gli scienziati.
Che la politica possa essere Arianna, colei che tesse le fila?
Milano, 15 febbraio 2006