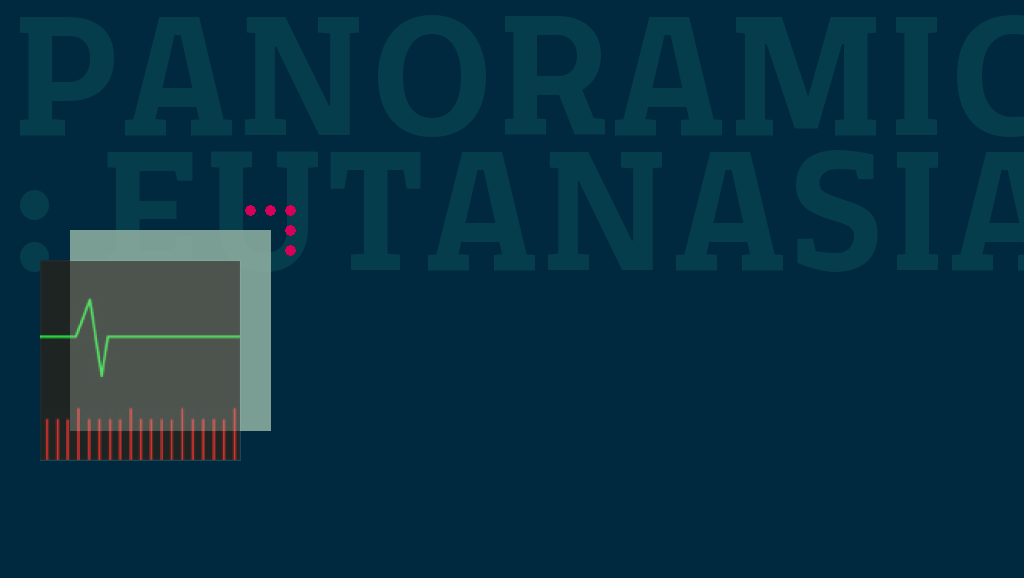La tematica della Responsabilità nell’innovazione è decisamente trasversale. I contributi che pubblichiamo spesso danno per scontato che il lettore abbia già una infarinatura sul campo dello scibile del quale si parla, e infatti spesso si tratta di approfondimenti.
Eppure in molti casi ci accorgiamo sarebbe utile avere una panoramica delle dinamiche che precedono la riflessione che portiamo.
A suo tempo parlammo del caso Englaro, ma più recentemente lo sviluppo delle biotecnologie, la conoscenza del genoma, le tecnologie di cura, la conoscenza in genere del funzionamento della macchina del corpo, portano sempre più spesso a doverci confrontare con scelte etiche riguardo al nostro destino, e questo si vede nella ricorrenza di queste tematiche anche nel nostro sito. Tali scelte infatti, anche quando possono dirsi individuali, in molti casi scatenano giuste considerazioni pubbliche in merito di etica, religione, politica, economia…
Virginia Sanchini, studiosa di etica teorica, etica pratica e filosofia morale, sta così porponendo una serie di panoramiche sui temi legati alla bioetica. Temi che si confermano delicati, spinosi, pieni di contraddittori, dalle molteplici sfaccettature. La Sanchini compie, appunto, una panoramica e ci conduce ai contributi che già sono presenti nel sito, dando così uno strumento per avvicinarci alla comprensione e alla contestualizzazione, aiutando, speriamo, il lettore a farsi una idea propria.
Eutanasia, suicidio assistito e direttive anticipate.
di Virginia Sanchini
É il sempre maggiore incremento tecnologico a dar vita a una della principali questioni bioetiche contemporanee: la questione dell’eutanasia. Se una certa forma di eutanasia, intesa tradizionalmente come sinonimo del ben morire o della buona preparazione spirituale alla morte, si può dire esistente da sempre, l’indubbio aumento delle capacità interventistiche umane non può che gettare nuova luce sulla questione sempre aperta dell’eutanasia e dell’interrogativo che essa solleva: se abbiamo una disponibilità sulla nostra vita, e dunque se è sempre moralmente lecito fare tutto ciò che è anche tecnicamente possibile compiere.
Nel suo significato odierno l’eutanasia viene definita come “un’azione o un’omissione che di natura sua, o nelle intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore (Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sull’eutanasia, 1980)”.
Nonostante numerosi siano i modi in cui si può parlare di eutanasia – attiva o passiva, volontaria, non volontaria o involontaria, diretta o indiretta – due sono le questioni che l’eutanasia sembra sollevare: qual è l’evento che sancisce la morte del paziente? Ovvero: quando si può dire che un essere umano sia organicamente morto? E inoltre: che cosa significa vivere? Quando si può dire che un essere umano stia realmente vivendo la sua vita? Se la risposta alla prima domanda sembra poter essere soddisfatta a partire da un orizzonte biologico, rispondere alla seconda questione esige invece lo spostamento dal piano biologico a quello esistenziale. Al primo interrogativo sembra cioè possibile rispondere in termini puramente biologici e lo si può fare mostrando che due sono i modi con i quali è stato individuato il momento del morire: da un lato la morte cardiaca – la morte del paziente veniva determinata sulla base dell’arresto cardiaco e della cessazione del respiro – dall’altro la morte cerebrale: si considera il paziente come deceduto quando l’elettroencefalogramma misura l’assenza di attività cerebrale. Se in passato morte era sinonimo di morte cardiaca, ora la concezione dominante di morte è associata alla cessazione di attività cerebrale. Il fatto che si sia ritenuto opportuno identificare la morte con la cessazione dell’attività sinaptica mostra tutta la difficoltà di operare la riduzione del concetto di vita alla sola sua presenza organicamente intesa. Se infatti la morte precede l’effettiva cessazione di ogni attività corporea, precede cioè la morte dell’organismo considerato nella sua totalità, sembra che anche il significato attribuito alla vita stessa debba mutare e che la morte non sopraggiunga sempre là dove cessi di esistere una vita biologica, ma che una morte biologicamente intesa possa sopraggiungere in una situazione di non vita, dove il soggetto sembri cioè in un certo senso essere già passato.
È proprio intorno alla questione su che cosa sia vivere, su come debba essere intesa la vita, che si organizza il dibattito filosofico sull’eutanasia.
Alla domanda fondamentale due sono, e sono stati, gli orizzonti di risposta: il paradigma della sacralità della vita e il paradigma della qualità della vita. Il paradigma della sacralità della vita afferma che ogni vita umana innocente è sacra. Due sono gli elementi su cui porre attenzione: si parla di vita umana – ciò esclude la versione orientale dell’argomento nel quale si dice che ogni forma di vita è in sé stessa sacra, cosa che permetterebbe una maggior forza dell’argomento stesso – e di vita umana innocente. Che cosa significa qui innocente e quale portata ha dire che solo quegli esseri umani che sono nello stesso tempo innocenti possono vedere tutelato il loro diritto sacro alla vita? Innocente è un termine tecnico; esso non sta qui a significare ‘moralmente puro’, ma ha un’accezione puramente negativa: una persona è innocente se e solo se, con la sua condotta sbagliata, non ha perso il suo diritto a non essere uccisa da altri – in questo senso, secondo quanto affermato da San Tommaso, la legittima difesa non provocherebbe la fuoriuscita dal recinto del sacro.
L’analisi della nozione di innocenza fa apparire le incongruenze di questa prima posizione: se la vita di un essere umano è intrinsecamente sacra, come può un gesto estrinseco comportarne la dissacrazione? Infatti: o la vita umana viene considerata come in se stessa dotata di una sua sacralità, sacralità che sarebbe da ascriversi alla specie homo, indipendentemente dalle singole vite individuali, oppure la nozione di sacralità deve appellarsi a qualcos’altro che non sia la nuda vita. Come avviene il passaggio dall’essere dotati di una vita sacra ad una vita umana non più legittimamente tutelabile? Ammettendo certo la gravità di un’azione omicida, potremmo affermare che la sua portata sia tale da privare l’uomo di una caratteristica che è intrinseca al suo stesso essere? Da qui il problema del paradigma della sacralità della vita, di fronte al quale sembra mostrarsi l’impossibilità di una via di mezzo tra le scelte estreme. Accanto al problema dell’innocenza, il paradigma della sacralità della vita mostra un’ulteriore, ben più profonda, problematica: quella di considerare sacro l’esser vivi e non invece l’avere una vita. Dire che ogni vita umana innocente è sacra significa affermare che l’esser vivo di ogni essere umano innocente è un diritto sacro inviolabile. Così facendo però il paradigma della sacralità della vita fungerebbe da tutela della vita biologicamente intesa e non della vita biograficamente considerata. E tuttavia: la componente biologica dell’esistenza è in grado di esaurire tutto ciò che una vita umana porta con sé? Basta essere vivi per dire di avere una vita? L’argomento contro la posizione della sacralità della vita è che in assenza di vita cosciente, sembra indifferente per il soggetto di tale vita vivere o morire. L’errore fondamentale del paradigma considerato starebbe cioè nel fatto di intendere la vita come sacra in senso meramente biologico anziché in senso biografico.
E tuttavia se vita è vita primariamente biografica e solo secondariamente vita biologica – così come sostenuto dal paradigma della qualità della vita – si può affermare che non sempre uccidere equivalga a privare un essere della propria vita: sottrarre al paziente cure che lo manterrebbero in vita solo da un punto di vista biologico, senza speranza alcuna di riprendere a vivere in senso pieno, non equivale qui ad uccidere l’individuo, ma solo a renderlo ‘non più vivo’. Nonostante l’enfasi positiva sull’importanza di una dimensione più profonda di esistenza, è però evidente il prezzo che questo secondo paradigma sembra comportare: individui in stato prenatale – come embrioni e feti – ma anche neonati e individui che per varie ragioni hanno perso la possibilità di perseguire una vita in senso pieno per un periodo transitorio o definitivo che sia – non solo anziani con varie patologie, ma anche individui in coma o in stato vegetativo persistente o permanente – verrebbero immediatamente considerati come tali da non avere una qualità di vita sufficiente, un vissuto tale da permettere la tutela della loro stessa esistenza. Se infatti il ‘non uccidere’ è rivolto unicamente alla vita biograficamente intesa, e se vi sono individui di varie età i quali perseguono, anche per un solo periodo, vite unicamente biologiche, allora essi costituirebbero un’eccezione rispetto alla regola stessa e non vi sarebbero ulteriori ragioni affinché la regola potesse essere applicata anche alla loro condizione.
Un esempio di questa situazione consiste nel caso di Terri Schiavo. Il caso di Terry Schiavo è ben descritto da Daniele Navarra nel suo Terry Schiavo: Innovation, Decision Making and the Future of Ethics, all’interno del quale l’autore solleva l’interrogativo cruciale di casi come quello in questione: “who is responsible for these decisions?”. Posto infatti che si tratta non di pazienti con malattie neurodegenerativo-progressive, dove la progressività della patologia permette che si possa riflettere sul da farsi, ma di pazienti che si trovano in un istante nello stato di malati da sani che erano, la questione diviene quella di capire chi sia responsabile della scelta, dal momento che lo stato di incoscienza del malato non permette di poterlo considerare responsabile delle sue decisioni. Nell’articolo in questione il problema della responsabilità della scelta era ulteriormente aggravato dall’incongruenza delle posizioni chiamate in causa: da una parte il marito di Terry chiedeva ripetutamente la morte della propria consorte giustificando la scelta come un “acconsentire alla volontà dell’amata”; dall’altro i genitori della giovane donna lanciavano costantemente appelli alla vita per permettere che la figlia non venisse privata del suo diritto di vivere. L’autrice sottolinea che tre sono le questioni problematiche sollevate dal presente caso: in primo luogo, all’ingente incremento della tecnologia medica, corrispondono sul fronte umano sentimenti di impotenza ai quali proprio quella tecnologia non sembra in grado di dar risposta; in secondo luogo, la stessa definizione di che cosa sia vita sembra essere problematica, difficoltà dalla quale seguirebbe il nostro collegare l’esser come vegetali all’esser come morti; in terzo luogo vi è poi il problema di stabilire a chi spetti il diritto di decidere su questioni di vita o di morte in circostanze come queste. Da qui la soluzione proposta dall’autrice è quella di pensare alla creazione di una possibile commissione eterogenea nella sua composizione – formata cioè da scienziati, bioeticisti, avvocati e membri rappresentanti della società civile – la cui completezza, maggiore certo rispetto alle singole competenze, permetta di affrontare in maniera più completa e d’insieme casi problematici come questo.
La questione sembra quindi essere la seguente: o si afferma che la vita umana è in se stessa sacra, senza possibilità di eccezioni, oppure sia nel caso del paradigma della sacralità della vita che in quello della qualità della vita si incorre in gravi problematiche che sembrano dimostrare la parzialità di entrambe le posizioni: il primo legato alla difficoltà dell’attributo innocente, e alla considerazione di vita come un qualcosa di meramente biologico; il secondo, proprio per la sua enfasi sull’aspetto fortemente biografico dei vissuti, tende inevitabilmente ad escludere dall’orizzonte di salvezza gran parte della popolazione, senza che l’effettiva decisione individuale possa avere rilevanza.
Ciò che entrambi i paradigmi non sembrano tenere in considerazione è cioè la questione legata alla scelta individuale di continuare o non continuare a vivere. L’enfasi sulla vita considerata per se stessa sacra ma anche l’approccio per certi versi escludente del paradigma della qualità della vita finiscono per lasciare da parte l’aspetto centrale della questione: l’autodeterminazione individuale. Bisogna cioè considerare il ruolo che la volontà del paziente ricopre nei due casi dell’eutanasia volontaria – dove l’eutanasia è esplicitamente e ripetutamente chiesta da un paziente competente ed informato – e in quello del suicidio assistito – ossia dell’azione cooperativa in cui, col consenso del paziente, il medico gli fornisce i mezzi, in genere farmaci, affinché egli ponga termine alla propria vita. A tal proposito nell’articolo Assisted suicide…Painless? si ricorda il caso inglese di Debbie Purdy, paziente 46enne affetta da sclerosi multipla che richiese una linea guida chiara e trasparente da sottoporre al marito, il quale l’avrebbe dovuta assistere in un possibile suicidio assistito. Proprio per questo il 23 Settembre 2009 fu pubblicato nel Regno Unito il documento “Interim Policy for prosecutors in respect of cases of assisted suicide“che rispondeva all’esigenza non così sporadica di avere delle direttive che fornissero la modalità attraverso la quale tale procedura dovesse essere attuata.
Numerosi sono gli argomenti a sostegno della disponibilità sulla propria vita e quindi in favore dell’eutanasia. Ci si potrebbe per esempio appellare ad un argomento utilitarista per affermare la liceità morale dell’eutanasia. Infatti la posizione utilitarista, affermando che le azioni sono giuste o sbagliate in proporzione alla loro tendenza a massimizzare la soddisfazione delle preferenze di tutti gli individui senzienti coinvolti e poiché nel caso della mia vita non ci sono altri soggetti coinvolti direttamente, afferma anche che è giusto ciò che massimizza i miei interessi o preferenze, negando che esista un diritto alla vita, men che meno un diritto inalienabile. Se dunque sono un paziente consapevole e il mio interesse consiste nel privarmi della mia vita perché ciò per me consiste più in sofferenza che in piacere, allora sono legittimato a farlo. Altra via per affermare la liceità morale dell’eutanasia avviene invece a partire da un’orizzonte liberale. Proprio perché la vita è un diritto, sembra che si possa affermare anche che esso è un che di rinunciabile: se i diritti sono infatti intesi a promuovere certi interessi, essi possono allora essere lasciati cadere qualora non vi siano più tali interessi. Quindi, quando un individuo competente dichiara che la vita per lui non è più un beneficio, non si può che rispettare le sue scelte autonome.
Numerosi sono gli argomenti che si possono opporre alle visioni utilitarista e liberale per affermare l’illiceità morale dell’eutanasia.
Da un punto di vista teologico si potrebbe innanzitutto far leva sull’individuazione della vita come di un dono, affermando che la vita ci è stata donata dagli dei – come sottolineato da Platone nel Fedone – o comunque da Dio, cosa da cui conseguirebbe il fatto che essa non è in nostro possesso e che dunque non possiamo privarci di essa. In secondo luogo, seguendo quanto affermato da Agostino nel primo libro del De civitate dei si potrebbe dire che vi sia un argomento ex autoritate contro l’eutanasia, ovvero il quinto comandamento ‘non uccidere’. Secondo tale argomento dal momento che l’eutanasia è una forma di uccisione perché a chi viene praticata l’eutanasia, questi muore, allora l’eutanasia è contraria al comandamento e quindi è moralmente illecita. A questo secondo argomento si potrebbe però obiettare che si tratta in realtà di un non-argomento e che comunque la traduzione corretta dell’espressione è ‘non commettere omicidio’, cosa da cui conseguirebbe perlomeno la non assoluta certezza di far rientrare l’eutanasia in questo caso. In ultimo, per sostenere l’illiceità morale dell’eutanasia all’interno di un orizzonte teologico si potrebbe anche seguire una terza via, ossia quanto sostenuto da San Tommaso nella Secunda Secundae. Qui, a proposito del suicidio (Tommaso non parla di eutanasia ma si potrebbe considerare quest’ultima come un caso particolare di suicidio), accanto alla tradizionale affermazione secondo cui il suicidio sarebbe contrario a Dio, egli afferma che non spetta all’uomo decidere quando morire e inoltre che esso è un’ingiustizia verso la società in quanto chi si uccide si sottrae ai doveri di giustizia della città, privandosi della sua responsabilità nei confronti del bene comune (cfr. Aristotele, Etica Nicomachea). Un cammino diverso per contrastare le conclusioni utilitariste e liberali, e sostenere quindi l’illiceità morale dell’eutanasia è stato percorso da coloro che hanno fatto proprio, seppur in modi diversi, l’argomento della legge naturale, sostenendo ad esempio che il suicidio è contrario alla naturale tendenza delle realtà di preservare la propria vita e, in particolare, contro il conhatus essendi proprio dell’uomo – tendenza tutta umana di incanalare ogni gesto per promuovere la vita e rifuggire la morte.
Il problema della liceità morale dell’eutanasia non può che sollevare anche dubbi relativi a che cosa comporterebbe legalizzare una tale procedura. Innanzitutto è da osservare che il diritto di suicidarsi non sembra implicare il diritto di essere aiutati a farlo, mentre il suicidio assistito ma anche l’eutanasia mostrano che i pazienti non sono in grado di togliersi la vita da sé e hanno quindi bisogno dell’aiuto di un medico. Ciò che però spaventa maggiormente coloro che si vedrebbero anche disposti ad una possibile legalizzazione della pratica eutanasica, sono le conseguenze della stessa legate alla tendenza che in questo come in altri casi affini si può verificare a causa del cosiddetto ‘pendio scivoloso’ (slippery slope): legalizzare l’eutanasia potrebbe comportare che dall’accettazione di casi più semplici – consenso libero e volontario di persone adulte e competenti – si passi in maniera diretta a casi più complessi e discutibili, senza poter avere controllo legislativo su questi ultimi.
Quello che si voleva qui mostrare era la problematicità insita nelle questioni biomediche, ma soprattutto il fatto che l’orizzonte del dibattito in materia, spesso ridotto a scambi d’opinione, sia filosoficamente sostenibile, ma non risolvibile definitivamente. A tal proposito importante è l’articolo di Angela Simone “Fine vita: la discussione fuori dai palazzi decisionali” dove l’autrice affronta il noto problema del testamento biologico e della difficoltà da parte del Parlamento italiano di trovare una legge che regoli tale questione. In questa sede viene discusso criticamente il fatto che i problemi sul fine vita compaiano solo ciclicamente nelle cronache dei giornali, nonostante il dibattito sociale sia già in atto, e questo perché tali problemi evidentemente necessitano di una spinta forte per costituire argomento di dibattito nei media nazionali. Vista la diffusa urgenza di dipanare i dubbi in merito alla questione del fine vita, almeno per coloro che ne hanno la consapevolezza, pur nell’attuale assenza di risposte, sarebbe auspicabile approvare una legge italiana per il testamento biologico, da molti anni in fase elaborativa, ma non ancora attuativa. Da qui l’importanza della chiusa dell’articolo della Simone: “Un’informazione che riesca a scardinare i polverosi mantelli del è vietato parlarne, dovrebbe dare spazio a queste discussioni non solo quando il clamore di casi estremi impone una dettagliata copertura mediatica. E dovrebbe evitarei dualismi nella rappresentazione di uno scenario complesso e multisfaccettato. Non è solo questione di essere a favore o contro l’eutanasia ma bisognerebbe interrogarsi su quali sono le paure, i dubbi e i bisogni dei cittadini su argomenti come il testamento biologico e il suicidio assistito, che trascendono la bioetica e la scienza. Proprio in queste situazioni così particolari, i ritrovati della moderna biomedicina e le innovazioni che si affacciano velocemente nello scenario clinico non sono più semplici strumenti da utilizzare a tutti i costi perché portatori di benefici. Una riflessione consapevole e responsabile e una comunicazione chiara e trasparente non possono che essere l’unica strada su temi in cui non è solo il singolo ad essere coinvolto, ma la famiglia, la classe medica e politica, e in sintesi la società tutta (corsivo nostro)”.