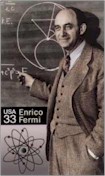
Perché questo Percorso
|
| Correlazione |
Si racconta che i fisici teorici lo considerassero il migliore tra loro e altrettanto i fisici sperimentali. Gli aspetti più notevoli della personalità di Fermi erano la versatilità, il rigore scientifico assoluto, l'intuizione dei fenomeni fisici --per i quali aveva una predisposizione naturale-- e la concretezza.
| Dal Forum |
|
Egli fu un innovatore nel modo di fare ricerca: della teoria non gli
interessava la "verità", ma l'applicabilità.
Questa integrazione fra teoria ed esperimento lo portò ad essere un precursore del nuovo
modello di ricerca scientifica in cui conoscenza teorica, verifica
sperimentale e applicazione tecnologica sono connesse da legami
inscindibili.
La sfortuna ha voluto che il primo esperimento di "big science", in cui Fermi è
stato qualcosa di più di un comprimario, fosse confuso con la "scoperta" della bomba
atomica (ma forse era proprio necessaria la mobilitazione bellica per concentrare
attorno al progetto Manhattan quell'ingente insieme di risorse che ha fatto decollare la
ricerca sul nucleare), pertanto egli viene ricordato come "padre della bomba".
Ciò può indurci a cogliere alcune delle principali problematiche relative al ruolo
della scienza e dello scienziato nella modernità.
La realizzazione della "bomba" fu la conseguenza di un progetto
tecnico-scientifico in cui decisioni politico-militari hanno pesato
almeno tanto quanto quelle della ricerca, se non di più ed è fuorviante
voler valutare oggi, a più di cinquant'anni di distanza, le responsabilità
morali di Fermi e degli altri scienziati che parteciparono all'esperimento di Los
Alamos.
| Links |
|
 La rivista Le
Scienze pubblica una Biografia di Enrico Fermi. Ne riproduciamo, qui
sotto, il Sommario
La rivista Le
Scienze pubblica una Biografia di Enrico Fermi. Ne riproduciamo, qui
sotto, il Sommario
La formazione di un grande scienziato
Gli studi da autodidatta diedero a Fermi le basi per affrontare la meccanica quantistica. L'approccio ai problemi, sia teorico sia sperimentale, resterà una caratteristica peculiare del suo modo di lavorare.
Il teorico in azione: la meccanica quantistica
Dopo la laurea Fermi si presentò a Orso Mario Corbino, che diverrà il suo maestro. Corbino lo introdusse negli ambienti scientifici internazionali e lo avviò alla carriera universitaria.
La cinetica dei gas e la fama internazionale
Le ricerche sul comportamento delle particelle in un gas perfetto portarono Fermi a confrontarsi con i più grandi fisici del suo tempo. Il congresso di Como nel 1927 fu per lui un successo internazionale.
Una nuova forza nel nucleo dell'atomo
La ristrutturazione dell'Istituto di via Panisperna, il favore di Mussolini e un importante congresso confermano il prestigio del gruppo di Roma. Ma la scoperta del 1933 non è subito compresa.
La radioattività artificiale e il potere della paraffina
La scoperta della radioattività artificiale apre la strada alle ricerche dei fisici romani, culminate nel riconoscimento del ruolo fondamentale dei neutroni lenti nelle reazioni nucleari.La fine del gruppo Fermi e la fuga negli Stati Uniti
Il tentativo di creare in Italia un centro di ricerche all'avanguardia non ebbe successo. In un clima politico sempre più pesante il premio Nobel rappresentò l'occasione per rifugiarsi in America.
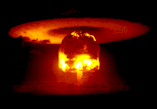
Dalle ricerche top secret nasce la pila atomica
Nei laboratori della Columbia University Fermi collaborò con altri fisici statunitensi ed europei per mettere a punto la reazione a catena. Il 2 dicembre 1942 entrò in funzione la prima pila atomica.
Da Los Alamos al test di Alamogordo
Gli ingenti finanziamenti del governo statunitense e la necessità di mantenere il segreto portarono alla fondazione del centro di Los Alamos. L'esplosione della prima bomba coronò anni di frenetiche ricerche.
Uomini di pace e signori della guerra
Alcuni dei fisici che avevano contribuito alla costruzione della bomba si impegnarono affinché l'arma non venisse utilizzata. Altri, tra cui Fermi, sostennero la posizione opposta. E gli USA diedero loro ragione.
I fisici hanno conosciuto il peccato
Dopo le esplosioni di Hiroshima e Nagasaki alcuni scienziati abbandonarono la fisica, altri si batterono per l'impiego pacifico dell'energia nucleare. Fermi collaborò alla costruzione della bomba ad idrogeno.
La scuola di Chicago
Fermi fondò una nuova scuola negli Stati Uniti e si impegnò nelle ricerche sulla struttura del nucleo atomico. Sollecitato dagli amici rimasti in patria contribuì al rilancio della fisica italiana.
Il caso Oppenheimer
Il fisico che aveva diretto il Progetto Manhattan fu condannato per spionaggio, nonostante le testimonianze di Fermi e di altri colleghi. L'episodio segnò gli ultimi anni di vita dello scienziato italiano.
Note biografiche
Letture consigliate
| Links |
|
Nell'aprile 2001, il New York Times ha ottenuto una trascrizione della registrazione
dall'amico al quale Edward Teller confidò le sue memorie sull'invenzione
della bomba all'idrogeno: William J. Broad, "Il padre segreto della bomba H: «Se potessi la farei
sparire»"![]() (articolo del NY Times tradotto e ripubblicato da La Repubblica il 25 aprile 2001).
(articolo del NY Times tradotto e ripubblicato da La Repubblica il 25 aprile 2001).
![]() Il
testo dell'articolo originale: William J. Broad, "Who Built the H-Bomb? Debate Revives", New York Times, April 24,
2001
Il
testo dell'articolo originale: William J. Broad, "Who Built the H-Bomb? Debate Revives", New York Times, April 24,
2001
«Dopo aver avuto un infarto, Edward Teller prese fiato e sedette davanti a un registratore per raccontare il suo punto di vista sulla storia segreta della bomba all'idrogeno. Il primo progetto, disse Teller, fu di Dick Garwin. E ripetè la sua affermazione, per non lasciare adito a dubbi. Così dicendo, il professor Teller, che oggi ha 93 anni, non cedeva gli onori di aver ideato la bomba gloria che attribuisce a se stesso ma chiariva come la sua idea fosse divenuta la più temibile arma del mondo. (...)
Edward Teller, figura tra le più controverse dell'era nucleare, ha avuto un ruolo centrale nell'invenzione della bomba atomica e della bomba all'idrogeno e nel distruggere la carriera di Robert Oppenheimer, che aveva diretto durante la seconda guerra mondiale il laboratorio sulle montagne del Nuovo Messico dove fu costruita la bomba atomica. In seguito, tuttavia, mise in discussione la moralità dell'ideare un'arma ancora più potente (...)
Garwin, che oggi ha 73 anni, è un fisico sperimentale che ha lavorato per vari decenni alla Ibm e oggi è membro del Consiglio per le Relazioni con l'Estero a Manhattan. E' favorevole a misure di controllo delle armi come il Trattato per la messa al bando dei test nucleari.
Fisico teorico, Teller è membro anziano della Hoover Institution di Stanford e direttore emerito del laboratorio militare Livermore. Accanito sostenitore delle Guerre stellari dell'amministrazione Reagan, più recentemente ha proposto l'idea di manipolare l'atmosfera terrestre per contrastare l'effetto serra.
Se la versione dei fatti data da Teller è esatta, lui e Garwin furono i principali artefici di una delle più spaventose invenzioni di ogni tempo, una bomba che utilizzava il potere di fusione del sole. Teller si era battuto per raggiungere questo obiettivo fin dall'inizio degli anni ‘40, molto prima che la bomba atomica apparisse. La sua idea era quella di sfruttare l'immenso calore prodotto dall'esplosione di una bomba atomica per innescare il combustibile all'idrogeno, fonderne gli atomi e liberare enormi quantità di energia nucleare. A Los Alamos, però, nessuno sapeva come
ottenere una cosa simile. (...)
L'idea, nota come implosione da irradiazione, era quella di costruire un grande involucro cilindrico che contenesse la bomba atomica a un estremo e il combustibile all'idrogeno all'estremo opposto. La vampata dell'esplosione della bomba doveva colpire l'involucro rendendolo incandescente e inondando l'interno dell'involucro stesso con una pressione sufficiente a comprimere e innescare il combustibile all'idrogeno.
Nessuno sapeva se l'idea avrebbe funzionato. Gli studi erano rallentati dai contrasti tra Teller e Ulam, ma anche dalla discussione, all'interno del laboratorio, se fosse eticamente corretto costruire una bomba all'idrogeno, dato il suo potere potenzialmente illimitato.
Garwin giunse a Los Alamos nel maggio del 1951 dall'università di Chicago, dove era stato uno dei protagonisti del laboratorio di Enrico Fermi.»
(William J. Broad, "Il padre segreto della bomba H: «Se potessi la farei sparire»", articolo del NY Times tradotto e ripubblicato da La Repubblica il 25 aprile 2001)