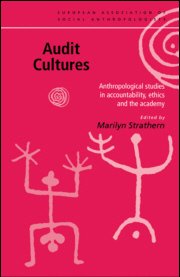|
Nella sua raccolta Audit Cultures, pubblicata da Routledge nel 2000, una delle figure più eminenti della comunità antropologica britannica, Marilyn Strathern, si propone di mappare "una nuova cultura emergente", in altre parole una forma di innovazione socialmente, moralmente e politicamente pervasiva, che chiama la cultura delle "new accountabilities" - cioè l'introduzione di protocolli standard per rendere "accountable" (valutabili e perciò responsabili) determinati tipi di performance. L'interesse, nel contesto di questa rubrica, di una rivisitazione di questo innovativo testo antropologico nasce dal fatto che esso esprime esplicitamente interesse e preoccupazione, da un lato per l'etica e la credibilità delle imprese, e quindi per il tipo di moraità che può essere introdotta da una "cultura della valutazione"; dall'altro, per il fatto che vi si affronta l'emergenza di una nuova categoria globale di pratiche "che non sono confinate in nessuna istituzione specifica", anche se si radicano nella contabilità finanziaria e prescrivono l'efficienza economica in termini di "buone pratiche" - in primis la pratica della valutazione.
La maggior parte dei saggi si concentra sull'impatto sociale della valutazione nella pratica accademica e sulle istituzioni scolastiche, ma questo fatto è meno interessante, ai fini della segnalazione del testo, della chiara e vasta analisi che Marilyn Strathern opera sulle culture della valutazione. In particolare, si mette in luce che:
1. l'auditing è una procedura di valutazione che deriva da, e ha effetti importanti su, situazioni sociali precise, nonostante tenda a formalizzarsi in protocolli che aspirano ad essere svincolati dal contesto, trasparenti e neutrali. In altre parole, si creano così delle performance che sono in realtà uniche e specifiche rispetto a contesti, personalità e relazioni e che possono essere investigate etnograficamente, cioè secondo una logica narrativa, o genetica, che privilegia la prospettiva storica e il coinvolgimento personale del ricercatore. Richard Harper ce ne dà un esempio con la sua etnografia del Fondo Monetario Internazionale nel capitolo 1. Si tratta di un caso di studio che mostra come i rappresentanti del FMI in missione in un paese in via di sviluppo debbano concertare la loro raccolta di dati macroeconomici con le autorità locali, a volte mediando tra i diversi livelli della gerarchia delle autorità locali, e mantenendo un coordinamento tra loro stessi, in modo da "costruire" coralmente un quadro sensato dell'economia del paese. In particolare, gli incontri debbono passare sia per fasi negoziali e di concertazione, sia per fasi "rituali" per potersi trasformare in "riunioni che contano" e produrre dei quadri consensuali per le politiche successive.
2. Per il modo in cui vengono implementate e innestate nel tessuto stesso di molte pratiche quotidiane e situate, tuttavia, i protocolli di valutazione spesso diventano "rituali di verifica" che è "quasi impossibile criticare in via di principio".
3. Nonostante ciò, le culture della rendicontazione sono appunto culturali e ciò si rende particolarmente evidente all'interno di istituzioni come la Commissione Europea, che comprendono non solo diverse lingue, diverse tradizioni e scuole di professionalità, ma anche, inevitabilmente, diverse concezioni e pratiche di governance (come mostra Maryon McDonald nel capitolo 4).
Grazie a questa doppia focalizzazione, sui contesti di pratica professionale (pubblica e privata) e sui sistemi di riferimento etico-morali, la critica contenuta in questo libro sull'emergenza di un unico modello di valutazione, monitoraggio e rendicontazione che tradirebbe e impedirebbe la libertà di ricerca nell'accademia è in realtà di interesse molto più vasto per chiunque voglia ragionare in termini di antropologia dell'innovazione riferita alla società nel suo complesso. I protocolli di auto-valutazione, di implementazione e monitoraggio delle policies, e di rendicontazione delle performance sono diventati uno strumento pervasivo sia nelle imprese e nelle corporazioni che nei governi e nelle istituzioni pubbliche, implicando ugualmente individui diversissimi, impegnati in pratiche disparate in diverse parti del globo (dal fare il formaggio in alpeggio all'implementare un progetto di sviluppo, dalla mungitura in una stalla padana alle procedure di rimborso di un ufficio assicurativo di New York). Un esempio per tutti, tratto dal testo (il capitolo 3 di Eleanor Rimoldi), riguarda l'ubiquità e la proliferazione dei controlli di qualità, dai contesti produttivi caratterizzati da un alto grado di automazione a quelli dell'apprendistato, dell'apprendimento individuale e della conoscenza tacita, a volte con effetti disperanti. Come mostra Rimoldi comparativamente nel caso dell'educazione universitaria e della formazione professionale in Nuova Zelanda, dalla formazione del filosofo a quella dell'estetista, i protocolli di valutazione tendono a diventare "la misura di tutte le cose", con gravi implicazioni per i modi in cui essi danno effettivamente nuova forma ai processi di apprendimento e di addestramento (per esempio, trasformando un processo continuo di apprendimento in uno stillicidio di "unità didattiche" mirate alla trasmissione di specifiche competenze, misurabili e valutabili.
Ciò che è di maggior interesse in questo testo, oltre alla denuncia dello stato di difficoltà in cui versa la libera ricerca e docenza in seguito a tutto ciò, è l'approccio antropologico adottato per "pensare all'auditing come a un actant" nel senso di Bruno Latour - cioè un oggetto (una pratica in questo caso) che viene investito di un potere e una capacità di azione propria. Questo approccio etnografico è originale e potrebbe essere molto utile nello studio di istituzioni politiche, organizzazioni economiche e strategie di management, fornendo "una rete di descrizioni che pertengono ugualmente alla valutazione, all'etica e alla politica".
|
 English version English version
In her edited collection Audit Cultures published in 2000 by Routledge, one of the leading figures of British anthropology, Marilyn Strathern, sets out to chart a new "kind of culture on the make", in one word a socially, morally and politically pervasive form of innovation, that of "new accountabilities". It is of interest for us to revisit this ground breaking text in anthropology because of its explicit concern, on the one side, with moral reasoning, ethics and the credibility of enterprises; on the other, with the emergence of a global set of practices "confined to no single institutions", which are rooted in financial accounting and prescribe economic efficiency in terms of "good practice" - the practices of auditing.
The fact that the collection of essays tends to concentrate on the social impact of auditing in the academic practice is of less interest to the reviewer, than its clear and open focus on the facts that
1. auditing is a procedure of assessment that as such results from, and results in, social situations, despite its aura of absoluteness, transparency, and neutrality. In other words, auditing creates performances that are unique to contexts, personalities and relationships and can be investigated ethnographically, i.e. through a genetic, or historical, logic of narrative and involvement (as shows Richard Harper in his ethnography of the International Monetary Fund in chapter 1 -a case study of how IMF officers on a mission need to liaise with local authorities, and in particular between different levels of the local authorities, as well as amongst themselves, in order to "build up" a meaningful picture form the macroeconomics data gathered in situ. In particular, meetings need both negotiations and ritualisation in order to transform them into "meetings that count" and produce consensual policy frameworks).
2. because of the ways in which they are implemented and engrained in the texture of local and everyday practices, though, audit cultures become "rituals of verification" that, as such, are "almost impossible to criticize in principle".
3. nevertheless, cultures of accountability are, after all, cultural and this tends to emerge particularly in those bodies of government such as the EU Commission, which incorporate not only diverse languages and traditions of civic professionalism but also, as a result, different concepts and practices of governance (as shown by Maryon McDonald in chapter 4).
Because of this double focus on context and on ethical systems of reference, then, the new accountabilities that are criticised as ultimately endangering freedom of research in the academy are of much larger interest to society as a whole - in that they pervade both private corporations and public governments by implicating individuals in "self-checking practices". One example for all is the ubiquity and proliferation of quality control checks (see chapter 3 by Eleanor Rimoldi), from the production contexts characterised by a high degree of automation to those of apprenticeship, individual learning and tacit knowledge, with at times despairing effects. As Rimoldi shows comparatively in the case of universities and professional training in New Zealand (spanning from training in critical theory to one in beauty therapy), protocols for control checks tend to become "the measure of all things", with grave implications for the ways in which they actually mould professional and training practices (for instance, by transforming them from a seamless experience of skill to one of digesting "units of learning" and separate competences).
What is of most interest in this book, beyond the denunciation of the plight of academy, is the anthropological approach adopted in order to "think of audit as an actant" in Bruno Latour's sense - that is an object (in this case a practice) which is endowed with power and agency of its own. This ethnographic approach is original and could be of use to the study of political institutions, economic organizations and in management studies, providing "a network of descriptions pertaining to audit, ethics and policy".
|
 This Web space, edited by Cristina Grasseni , is dedicated to a survey of sites
and publications addressing the issues of innovation and responsibility. It
considers a number of "local" ethnographic issues and includes reflections
and ideas on the globalising aspects of innovation and responsibility
This Web space, edited by Cristina Grasseni , is dedicated to a survey of sites
and publications addressing the issues of innovation and responsibility. It
considers a number of "local" ethnographic issues and includes reflections
and ideas on the globalising aspects of innovation and responsibility
 Leggi la PRESENTAZIONE
Leggi la PRESENTAZIONE
 Read the INTRODUCTION
Read the INTRODUCTION